‘Dentro la forma, la domanda- l’opera e lo specchio’
| 1 imagesDi ogni mio lavoro conosco soltanto il ‘prima’ , se mai posso dire del ‘ cosa succede’ quando mi avvicino ad un materiale grezzo, del ‘cosa cerco’ o di ‘che cosa mi spinge’; dunque conosco in qualche modo ‘ il prima’ e ‘il mentre’, ‘del dopo’, cioè del risultato, praticamente non so nulla: non vedo mai la faccia dell’opera che mi esce dalle mani. Il lavoro, dopo aver messo la firma, mi volta sempre le spalle.
In un certo senso mi ignora, se mai, mi trascina .
Le sensazioni che possono essere tratte dalla Forma composta è un fatto che lascio a che guarda: una volta che ho messo il punto non posso che ascoltare, se parlassi dell’immagine allo specchio mi chiuderei proprio in una specularità senza uscita e fallirei nella mia ricerca dell’incontro, perché nell’ascolto, anche quello più improbabile, tocco il diverso da me, il diverso che mi definisce,
C’è uno scarto di contiguità tra ‘contatto’ e ‘diverso’ e in questa sospensione si esprime l’Eros, come un fluttuare di domande tra frammenti di risposte.
L’invenzione è solo una testarda ricerca della forma che esprima strutture tensionali, necessarie, sotterranee, qualcosa che ha a che fare con la prima domanda di senso, una domanda inquieta, infantile.
Una sorta di: Cos’è ?
L’invenzione è un po’ il mio percorso di conoscenza, un viaggio che non parte dal pensiero, ma dallo sciogliersi di nodi interiori che via via diventano segni e codici e forma di insiemi significanti.
Arriva poi alle parole e al pensiero; l’orizzonte si sposta, ogni volta, più oltre.
Inconscio e coscienza si sollecitano e si scoprono a vicenda.
Dopo i normali approcci esplorativi con la matita credo che i miei primi scarabocchi volessero essere una figura: certo è che la prima cosa leggibile fu una figura, non alberelli e casette, anzi non ricordo di averne fatti molti, anche se il mio primo “dipinto “ ad olio doveva essere un prato con due alberi e un fiume nel mezzo, ma sembrava una faccia; avevo quattro anni.
Ricordo invece che più tardi disegnavo “mappe” di case, quattro pareti arredate, entro le quali far abitare le mie pupazze di carta.
A Sirolo, vicino a mia nonna abitava un pittore, ed io quando ero lì in vacanza, andavo qualche volta da lui. Avevo nove, dieci anni, ma non è durata per molto questa sorta di scuola, perché mi sentivo troppo stretta , dovevo ritrarre qualcosa e questo mi annoiava, ricordo un eterno vasetto di begonie.
Quello che il signor Roberto voleva da me aveva ovviamente senso , ma quello che volevo io non era essere brava a fare una bella cosa, io dovevo esplorare una figura.
Ero io quando fossi diventata grande? Mia madre? Non lo so, forse un po’ tutte le donne che conoscevo. La forma di un popolo a cui appartenere?
Ogni punto, ogni segno era per me un viaggio, e quando per caso sentivo di perdere perso il filo intuito, mi trovavo persa, col sangue che mi avvampava fino alle orecchie; era come un gioco prepotente dal quale non potevo sottrarmi, cercavo qualcosa di indefinito che mi era essenziale. Non sapevo cosa fosse, ma entrare in quel territorio, che io stessa in qualche modo ricostruivo, mi dava eccitazione e insieme calma Ne ero calamitata.
Cosa stessi inseguendo veramente non ha ancora un vero nome, ma non ho fatto altro che sentirmene attirata.
Anche la mia avventura autoanalitica, approdata a buon fine, e confermata da chi di dovere, è stata una continua necessità di ascoltare, scavare, toccare, cercare di vedere, di capire.
Vedere l’origine del presente, le connessioni che stanno dietro a quello che si vive, la prodigiosa composizione e armonia dell’incomprensibile sono il mio rovello di fondo.
Credo che ogni essere vivente sia soprattutto una domanda, inizia che è una domanda solo tensionale, formulata senza termini e domanda rimane per tutta la vita anche quando, per strada, organizza idee e concetti cui affidare la direzione della sua ricerca. Io, per sicuro, sono una domanda attorno alla prima domanda, forse sono solo un punto interrogativo.
Parlare di un punto interrogativo è come avventurarsi senza orologio tra continui paradossi temporali: il tempo e la sua soggettiva/oggettiva segmentazione in passato, presente, futuro; il tempo e la sua realtà dissolvente, il tempo e la sua realtà di permanenza …
Il cronologico, il mentale.
La griglia spazio-tempo fornisce forse le prime coordinate alla struttura psichica, è un processo che si struttura già nel feto chiuso nel corpo materno, un corpo vivo, quello della madre, immerso, a sua volta, nel vivo organismo dell’ambiente; il battito cardiaco, l’andamento dei passi, la vibrazione delle parole, l’aria e i liquidi che scorrono si traducono in scansioni e ritmi che forniscono al neonato un primo abbozzo di segni per cominciare a disegnare il mondo, misurando e creando ( nel modello di tempo e di spazio che la mano esperimenta mentre gioca col proprio cordone ombelicale o quando, più tardi, scopre se stesso e si esplora) la forma delle forme, quella del proprio corpo distinto dal corpo della madre.
E’ il momento di un processo che , data l’incommensurabilità delle misure in gioco e considerata la diversità delle forme, si potrebbe dire esista da sempre
La vita umana è l’evento dell’ultimo secondo.
Di certo il pianeta non ne ha ancora coscienza, solo sintomi (Odisseo vuole, Faust vuole; estrapolano, segmentano, scelgono ed escludono, incrementano e distruggono, operano secondo leggi proprie, indifferenti ai grandi nessi di congruenza organica).
Ogni particella nasce dove le capita di nascere
Forse prima di venire al mondo siamo particelle di un flusso cosmico e navigando tracciamo i segni di tutti gli orizzonti possibili.
Poi nasciamo e ci vestono di modelli già predisposti, cuciti lì, dove siamo capitati.
Io, per sorte e per caso, continuo a vivermi come un punto fatto per scorrere in un oceano lento che respira una continua attività generante, sciolto, senza recinti, e non tra paesaggi rocciosi e puntuti.
Come sta una sardina in montagna in mezzo agli stambecchi?
Male e forse non ha parole per dirsi sardina specie se il termine nel vocabolario degli stambecchi è letta come una variante di stambecco; sarà sempre vista come uno stambecco da correggere.
E’ una storia che si ripete, specie quando una parte, la più forte, non sa gestire il rischio delle differenze.
E’ un vero peccato, pensiamo solo a quante storie potrebbero scambiarsi, sardine e stambecchi, e quanto più spazio ne verrebbe alla mente di entrambi.
Il mio sostanziale senso di appartenenza ad un Sistema Tutto è il bagaglio con cui mi sono trovata ad impastare la mia prima idea di mondo ; è certo la matrice della mia curiosità e del mio continuo innamoramento per ciò che è vitale; è certo la dote naturale di ogni essere dal filo d’erba in su, il serbatoio nutrizionale, inesauribile, compreso nel kit di fabbricazione. Ma invece sono venuta in mezzo a codici che danno il mondo come l’oggetto da conquistare per sentire di esistere, in mezzo a teoremi dove l’idea di competizione è assiomatica; dove le forme di controllo attivate continuano a produrre raffinate specializzazioni
Il mio gatto continua ad essere naturale forse perché nessuna sua teoria sul mondo è intervenuta a convincerlo d’essere più grande del mondo.
.
Se i soggetti potessero sentirsi parti di un grande contesto, intero, vitale, organicamente congruo, scoprirebbero la felicità avventurosa di un continuo processo di conoscenza, ma indebolirebbero l’immagine di essenzialità che ogni potere verticistico si arroga, un Padre deve essere perennemente il più forte per legare il figlio ad una perenne dipendenza.
Ovviamente un alimento connaturato e stimolante costituisce un disturbo per le ragioni delle sudditanze imposte, ed infatti lo svezzamento è una delle pratiche più precoci messe in atto da una cultura: non sei parte di un qualcosa più grande di me, di cui Io non vedo i confini, sei mio.
Mia madre forse ha dimenticato di svezzarmi o inconsciamente non ha voluto farlo per lasciarmi uno spiraglio sul suo mistero generante dove l’indifferenziato, lo spalancarsi dell’originario Chaos, incontra continuamente il Cosmo, l’ “ornamento”, il differenziato posto in ordine.
E’ il luogo delle relazioni fluide estranee alle sclerosi del possesso.
Forse è per questo cordone sopravvissuto, questo regalo fatto quasi in segreto, che vedo semplice la felicità e patisco tutte le dicotomie imposte come il più opaco e insieme il più feroce modo di essere nel mondo.
Una stupidità paludata e chiassosa che si autoconferma.
La difficoltà di intendersi produce sempre un senso di estraneità; per quello che mi riguarda, provo da sempre con disagio la sensazione di non appartenere veramente al gruppo in mezzo a cui mi trovo, uno scarto non afferrabile fa slittare fuori schema il senso dei linguaggi; succede quando, stando in mezzo ai propri simili, questi, nel momento stesso che ti dicono simile a loro, dimostrano di non vedere i tuoi contorni e te ne attribuiscono altri , allora si tenta di correggere la relazione attraverso cui dirsi, ma la situazione non cambia anzi si ingarbuglia, le parole sono parole dello stesso vocabolario, ma la sintassi è diversa; ho impiegato molto tempo e molta fatica per capire che era un problema di categorie sintattiche.
Adesso lo so ma lo scarto continua: è difficile comunicare questo genere di diversità, occorre che tutti e due gli interlocutori si pongano su un piano metasintattico.
La nostra cultura, per suo statuto , si pensa all’apice della piramide (subito sotto Dio), quindi non le è facile prevedere, per se stessa, piani di metalivello capaci di vedere limiti e antinomie.
La scollatura sulle categorie di base , flusso e segmentazione, organicità e dicotomia, portano certo a sensi diversi; penso che il mio gatto , al mio posto, avrebbe lo stesso problema: due diverse, inconsce visioni del mondo, la mia e quella del mio ambiente hanno continuato a far slittare i significati nel rispettivo porsi dell’uno verso l’altro: su questa faglia, rimastami per tanto tempo invisibile e quindi sconosciuta, è nata e si è aggrovigliata la mia sofferenza, e sempre lì è avvenuta più tardi la mia presa di coscienza e la realtà di una solitudine.
I MODELLI
Mi cattura sempre il modo con cui i bambini guardano , quasi cancellata anche a me stessa per non alterare in nessun modo quello che sta accadendo, vivo gli occhi dei bambini come un orizzonte sulle armonie possibili; si lasciano abitare da ogni stupore, si dilatano come cielo carico di vento, abbracciano e si lasciano abbracciare, cercano.
Questa loro potenza è la saggezza della filogenesi, è fatta di innocenza e di fame ed è la più grande risorsa naturale della nostra specie, una risorsa destinata ad entrare nel processo con il quale la psiche persegue il proprio progetto di base per l’autoconservazione, lo sviluppo, la riproduzione, il rapporto con il gruppo e con l’ambiente.
Il bambino è ancora natura e per lui sono aperte tutte le possibili direzioni formative.
Tutti introiettiamo modelli e con questi formiamo categorie per gestire il patrimonio naturale con cui nasciamo; l’insieme strutturato di questi modelli è la creatura più potente che la nostra specie riesce a partorire: la cultura.
La natura partorisce i bambini, ogni cultura partorisce le forme del maschile e del femminile, le loro relazioni, i recinti e gli stemmi degli abiti, l’opportunità e la verità dei pensieri, l’oggetto del bene e del male, le strategie più efficaci per convalidare e/o imporre la propria visione del mondo.
La psicoanalisi, come pure la semplicità del linguaggio quotidiano, dice che le difese messe in atto scoprono la natura del pericolo da cui ci si difende; tirate le somme si può dire che l’incubo che perseguita da secoli i sonni collettivi della psiche occidentale (e mi fermo a questa) è il sentimento di impotenza; il bisogno risarcitorio? Il delirio di onnipotenza
Un tale bisogno di forza, nevroticamente necessitato, porta i soggetti che lo vivono a sviluppare tutta una serie più o meno aggrovigliata di camuffamenti e di depistaggi per nascondere le proprie fragilità temute: viene curata in modo parossistico l’immagine con cui mostrarsi per non correre il rischio di tradire rammendi o sfilacciature.
La nostra cultura per meglio controllare tende a reificare i concetti astratti appiattendo le relazioni che i concetti rappresentano; non a caso la paura, vasta gamma di relazioni possibili tra soggetto e senso del pericolo, è stato schiacciata sulla valenza della codardia mandando perduta ogni carica di stimolo intellettuale: ne risulta un significativo disvalore e la rimozione del sentimento.
Nessuna incongruenza: una cultura a forte carattere patriarcale si trova necessariamente costretta, e fin dall’inizio, a massimizzare la valenza della forza e del coraggio, della competizione e della conquista.
Il bisogno di possesso che ne deriva tende a crescere in modo esponenziale, è una testimonianza compulsava del proprio potere di conquista, il deterrente più diretto contro l’aggressività dell’avversario.
Una millenaria cultura di soli maschi, con femmine socialmente zittite, è di necessità una cultura monoculare, irrigidita sulla difesa del privilegio e priva della visione prospettica propria della biocularità; ugualmente orbi sarebbero stati i risultati se si fosse verificato il caso opposto e se l’accanimento tattico fosse stato altrettanto ossessivo.
La paura della propria impotenza, rimossa perché insostenibile, rimane insostenibile anche all’inconscio e deve quindi essere continuamente proiettata sul soggetto che volta volta ne evoca il pericolo; nasce la necessità del nemico psicologico, il vomito fisiologico dopo l’avvelenamento, il salvagente nevrotico della fobia.
Le persecuzioni, le guerre.
E’ un processo senza fine che tende a serrare i propri ritmi ossessivi in un’ottusa coazione a ripetere, non c’è liberazione, non è andando avanti che si risolve il problema, ma tornando completamente indietro; quando un problema di matematica non arriva ad una soluzione, bisogna cambiare foglio e riconsiderare l’intero fatto e su questa nuova visione reimpostare la questione : vanno rivisti ex novo gli elementi agenti e le relazioni che li interessano, riconsiderate le incognite e gli intervalli entro cui posizionare la variabili.
Nella vita occorrerebbe questo coraggio, anche se, in questo caso, l’operazione è infinitamente più difficile; ma bisognerebbe averlo proprio perché insistere su uno schema errato è deleterio per esseri dotati della capacità di apprendere: nella vita tutto è comportamento e ogni comportamento è a sua volta comunicazione e quindi motore di cambiamento per la relazione interessata , quindi matrice di altri comportamenti, altri apprendimenti.
Dai grovigli nascono grovigli, una valanga che si consolida creando nuovi garbugli, paradossi.
Ma purtroppo non c’è foglio di carta che si possa cambiare.
Occorre fermarsi e riconsiderare, operare quello scavo che Bacone chiamava Pars Destruens, e che oggi possiamo dire essere la presa di coscienza degli apprendimenti strutturali da correggere.
Credo che nessuno pensi al futuro della nostra specie come ad un processo proiettato verso l’aumento numerico delle braccia e delle gambe dei componenti, sappiamo che il compito è da un’altra parte, nell’evoluzione psichica, mentale e affettiva, più difficile e soprattutto poco sensibile all’aiuto della bionica.
Non è un processo automatico e credo valga la pena, prima di esserci costretti per patologia dell’intero sistema, di rivedere alcune ipotesi di mondo e capire da dove nascono i nodi che ci stringono.
Per cambiare sistema assiomatico non c’è altra strada: occorre rivedere le premesse.
Sarebbe una buona direzione quella di ritrovare esperienze di senso più profonde e intellettualmente più critiche.
Ce ne sono di vie possibili, anche lo spazio aperto e il tempo lento che allargano gli occhi dei bambini possono insegnare ad accogliere, nel soprassalto della paura, il nuovo che sorprende e l’inaspettato che vuole essere conosciuto
Rivedere le ipotesi e cambiare le premesse, la scienza l’ha fatto innumerevoli volte, ma tutte le rivoluzioni, anche quella dei quanti e della metamatematica di Goedel, sono restate nel pentolone della fisica di Aristotele, grande contesto sistematico mai uscito dalla caverna di Platone; quegli schiavi, restando sempre con la schiena rivolta all’apertura, continuano a guardare le ombre sul fondo; nei secoli, hanno evoluto la propria hybris e si sentono in grado di gestire, sulla base delle ombre senza colore, lo sconosciuto oggetto del desiderio, l’alchemico proliferare della vita oltre l’apertura della caverna.
Più di cento anni fa, Russell, mentre metteva mano alla formalizzazione della logica, si è imbattuto nella famosa antinomia e l’ha risolta : eureka, l’elemento non è la classe; sta a dire che un sottosistema può solo descrivere il sistema da cui riceve senso, non può dargli legge, né governarlo.
Ma neanche questo salto cognitivo è stato capace di svegliare e far uscire dalla pentola la nostra visione inconscia del mondo , noi continuiamo a mangiarne i paradossi senza capire da cosa dipendono le nostre gastriti.
Certe perseveranze costringono tutte le energie dentro un’unica ossessione, una coazione a ripetere condannata a non vedere mai il proprio schema.
IL TEMPO DILATATO
Vivo il tempo come l’istante un flusso che vede le ere e ignora gli anni, e la mia esistenza, nel confronto, diventa una cosa proprio piccola , tanto inutile di per sé quanto però essenziale, come è essenziale a un circuito ogni suo punto.
La contraddizione apparente è in effetti uno scarto fertilissimo.
Attorno, ho sempre tutte le quinte di scena: l’infanzia non è “da ritrovare”, non l’ho mai lasciata è solo cresciuta insieme con il mio severo principio di realtà, né l’ho separata dall’adolescenza, né ho staccato questa e quella dalla maturità; è come se, nelle mie cellule, coesista l‘esperienza della conchiglia fossile e il patrimonio di creature ancora lontanissime dal nascere; la vita è un tessuto di tanti fili diversi giocati con la carne e con i linguaggi, un microscopico tappeto da preghiera che non smette di accogliere e raccontare storie; è semplice perché deve essere capito, è complesso perché deve essere resistente, è una delle tante tessere colorate di senso dentro un processo corale dove nascono molte parole e scorrono molti passi.
Gesti di conoscenza; mi sento felice quando la mente riesce a farsi corporea e sottile per scivolare tra forma e forma, quando posso interrogare i contorni delle cose e delle relazioni, quando vado alla ricerca dei segni per nuovi linguaggi, nuove leggi per nuove ipotesi alle domande; qualcosa da offrire alla legge del padre perché, per amore, non faccia vivere i recinti e patire i tagli ritualizzati;
L’educatore diceva di separare perchè la separazione permette di annullare sempre una parte, quella sconveniente , anche la mia voce di donna per secoli è stata una delle parti sconvenienti; non dovevo attardarmi a distinguere, stare in mezzo al bene e al male chiedendo quali fossero i loro rapporti e le loro ragioni; guardare, interrogare e cercare le differenze per distinguere una via da un’altra e sentirmi partecipe dell’intera coreografia.
Da sempre invece è proprio lì in mezzo la voglia dei miei giochi inventivi, delle mie avventure conoscitive; purtroppo il processo che porta alla distinzione vive di reciprocità e la reciprocità in un contesto di rigore gerarchico presenta notevoli rischi di eterodossia.
Risultato : sono claustrofobica.
LA FERITA E L’ARTE
C’è una teoria che alcuni dicono invalsa da tempo, una teoria secondo cui ‘non si confonde più l’uomo empirico con l’artista’ per cui le ferite di un individuo non hanno nulla a che vedere con il suo fare arte dal momento che ‘i traumi e il male fisico possono ridurre lo spirito, ma non creano. Sono mera negatività, la creazione è mera positività’.
Non sono d’accordo con questa bipartizione, anche se mi rendo conto che in un contesto culturale basato sulla dicotomia, la conclusione è congrua; se il ‘bene’ viene assiomaticamente separato dal ‘male’, anche il ‘positivo’ deve essere tenuto lontano dal ‘negativo’: monadi, la ’res extensa’ non toccherà mai la ‘res cogitans’.
Resta il fatto di chiedersi che cosa, di tutto il bagaglio di vita che è nell’arte, la teoria in questione riesca a mettere nell’asepsi della ‘mera positività’.
Per me, che vivo e penso la vita come organicità complessa, le cose possono essere dette diversamente, soprattutto senza dover ricorrere ad assoluti metafisici: per prima cosa l’uomo empirico e l’artista sono due diversi momenti dello stesso processo, momenti che però si situano su due piani gerarchicamente distinti: il primo livello conta le esperienze di un singolo vissuto cronologico, il secondo, che è invece un metalivello a tutti gli effetti, nasce da una diversa fatica: dall’elaborazione psichica e dalla sublimazione del primo; se nel primo si vedono i fatti, nel secondo si sentono le strutture che stanno sotto a quei fatti , le proprie ferite diventano domande per le Ferite, le chiusure si trasformano in aperture su più vaste accoglienze.
Il passaggio dal primo livello al secondo è esso stesso un processo in divenire e la struttura psichica di senso, espressa dalla forma dell’arte, esprime profondità diverse ed è proprio questo aspetto che differenzia opere storiche da opere metastoriche, opere di una corrente o di una moda da opere che continuano ad avere voce oltre lo scorrere di tempo e spazio.
Credo che ognuno di noi sia come una sorta di imbuto la cui parte alta, aperta verso l’esterno, coglie gli stimoli che arrivano, e ne manda di propri, ma, a mano a mano che si entra e si affonda nel corpo conico, queste relazioni sfumano i propri contorni, riducendosi a colori, odori, segni, mentre si mettono sempre più a fuoco i contesti , quasi un ‘dx’ che dall’elemento più contingente e concreto tende a percorrere tutta la scala fino al contesto dei contesti, l’astrazione complessa che li connette tutti.
Si arriva lì, vicino all’asintoto, dopo che si è superato il punto critico, il punto che delimita il nostro sentirci solo individui, allora si entra pericolosamente nella zona dei molti, dei tutti, nella metafora dell’appartenenza; il bambino ha appena ferito il proprio Narciso misurandolo sul corpo smisurato della madre, il pianeta che può accogliere e può sottrarsi; ha appena intravisto la differenza tra significante e significato, la domanda di senso è la più grande e libera possibile e il dolore e la felicità sono oceaniche.
Un’opera che mette anche un solo piede lì è un momento di vita indicibile.
La cultura antisistemica teme più di ogni altra cosa l’eterodossia di tutto ciò che ha grande forza connettivante.
IL MIO LAVORO
Il mio impegno da professionista inizia a metà degli anni ottanta, dopo periodi frammentari e clandestini alternati a lunghi silenzi
Dentro di me ha lavorato sempre una continua ricerca sui rapporti e le connessioni che intrecciano persone e regole.
Non a caso i primi temi che si sono presentati alla mia curiosità sono quelli del chaos, del femminino e dell’eros, metafore a forte carattere relazionale e sistemico; la necessità mi nasce dagli strappi della dicotomia.
Le prime opere di quegli anni nascono soprattutto da una irresistibile voglia di sfida e di gioco.
Sembra strano ma queste tensioni si legano fortemente anche al bisogno di esprimere la ridondanza primaria del materno e insieme i suoi controaltari: la secchezza dell’educazione coercitiva e la prostituzione normalizzata.
In seguito mi si chiarisce meglio il bisogno di tentare rapporti immaginari tra gli elementi dell’opera: sento la composizione come una forma coerente pur nei suoi continuamente provocati disequilibri; è il luogo per sperimentare la possibilità di sempre diversi linguaggi, quasi un gioco continuamente a rischio per inventare sistemi.
Nel ‘92 realizzo un ciclo di opere ispirandomi alla poesia di Saffo.
Mi attira quel complesso continuum che pervade la sua intensa affettività vista nelle articolazioni multiformi di figlia, donna, madre, amante.
La sua opera è l’espressione di una sensibilità raffinata e l’interezza erotica dell’archetipo femminino.
Trovo poi nel mito di Pandora la figura emblematica di una paura rimossa.
La paura di Zeus che punisce il regalo del fuoco è una metafora e la proiezione del disagio di tutta una cultura di uomini per il potere naturale generante.
Il femminino è la minaccia oscura, il vaso è il ventre dell’eros primigenio, i mali che ne fuoriescono sono il chaos che minaccia quell’ordine lineare partorito dal pensiero.
Il ‘parto del pensiero’ porta il verbo ad essere esclusività dell’uomo, secondo una complicata appropriazione del potere creativo, quasi un rovesciamento del furto prometeico.
Il mito di Pandora fonda la dicotomia bene/male, Pandora, la tutta bella di doni divini e il suo vaso, la cavità gravida di mali.
Nel 1995, allestisco a Portovenere, a cura della GBArte, una mostra sul Corpo.
Sono soprattutto raccolte opere sul senso del corpo femminile
Se, come accade, l’identità dell’io si struttura nell’incontro con l’altro da sé, allora non è trascurabile il fatto che per la femmina ‘l’altro da sé’ è contenuto nel ‘sé’: il soggetto vive per sua natura situazioni paradossali ed è naturalmente dotata di strutture psico-fisiche adatte a produrre i metalivelli adatti a superarle.
E’ costruita per cogliere la complessità e il suo cervello, come risulta da studi recentissimi, è specializzato nell’uso e nella comprensione dei linguaggi.
Per il maschio è diverso, ‘l’altro da sé’ è ‘fuori’e nel fuori avviene l’incontro: una netta coerenza lineare semplifica il processo; nessun rischio di paradosso, nessuna necessità di strutture di metalivello.
Il cervello del maschio presenta infatti una specializzazione nel cogliere figure in movimento.
Il corpo del femminino rimanda dunque alla grande complessità psico-fisica dell’organico e ne è metafora.AAA ( emozione-teoria)
Nell’autopresentazione a catalogo ‘Il Corpo …tra il bene e il male, nella filosofia e nella scienza’, ipotizzavo che l’atteggiamento con cui si guarda al corpo è indicativo del modello che struttura il senso della vita e la stessa visione del mondo.
Analizzando il significato che la nostra storia ha dato alla corporeità e all’Eros ho espresso una mia teoria sulla dicotomia come sistema assiomatico fondante la cultura occidentale.
La dicotomia, per rispondere ad un bisogno di controllabilità e di sicurezza, divide nettamente l’intero organico in due parti,: una, la coscienza razionale, da eleggere a riferimento, perché vede controlla e legifera , e l’altra, l’affettività, da ritenere pericolosa e sospetta perché porta l’ombra all’interno del cerchio primitivo aprendo allo sconosciuto.
Il Logos è il luminoso Apollo che sconfigge il serpente ctonio, la Materia; il primo si identifica con la Mente e, sul piano etico, con il Bene, la seconda si identifica con il Corpo e col Male.
Una tale struttura dicotomica, ponendosi come contesto dell’intero sistema vivente, e non come suo sottocontesto, instaura dinamiche antisistemiche.
Le ricadute paradossali di questo processo sono innumerevoli e sottendono molti dei mali che patiamo.
Una delle prime conseguenze colpisce la relazione primaria quella che fonda tutte le altre, la relazione tra soggetto e ‘altro da se’’; tale rapporto non presenta l’intero ventaglio di alternative, ma solo una sua illusione , infatti non si apre all’accoglienza per chiudersi nell’intolleranza, ma parte da metà strada, dalla tolleranza, cioè da un’ammissione di disponibilità a sopportare condizioni ritenute già sfavorevoli o potenzialmente dannose
Nel progetto “L’Androgino e il Serpente” tento gli aspetti complessi e fluidi della sessualità: l’universo femmina-maschioconfligge con la logica riduttiva della separazione, specie se compulsiva.
Con “La seduzione- ossessione e paura nei Trattati degli Inquisitori”, mostra del ’97 per la Rocca Malatestiana di Montefiore-Rimini, lavoro sui rapporti che legano l’intolleranza alla paura del diverso sentito come portatore di disordine.
La seduzione è infatti il linguaggio dell’Eros primario, la vertigine dell’Intero nella sua massima complessità
Dal punto di vista strutturale la caccia alle streghe è forse il modello perfetto di tutte le diverse forme di intolleranza, il processo fobico per eccellenza che ha nel “Malleus maleficarum”, e nella sua struttura autoconfermante, uno statuto terribile in cui tutto il sapere del tempo entra per serrare i ceppi attorno ad un essere umano.
Si è nel 1485 e papa Innocenzo VIII con la Bolla “Summis desiderantes affectibus” ordina a due domenicani tedeschi, Kramer e Sprenger, di compilare un esaustivo corpo di leggi per combattere la stregoneria, più tardi, nel Settecento inoltrato il Codice Teresiano si preoccupa ancora di studiare congegni di tortura idonei a permettere di infierire il più a lungo possibile sul soggetto cercando di evitare che la morte sopravvenga troppo presto. Solo uno stato patologicamente ossessivo può tanto.
Un filo sotterraneo lega il diverso e la strega al ventre di Pandora: la paura spinge il torturatore a proiettare sulla vittima seduttrice la propria impotenza di sedotto.
Le ricerche attorno a questo argomento mi portano ogni volta a constatare la particolare fragilità psichica del persecutore: la codardia rimossa.
Il chaos della strega e il cosmo dell’Inquisitore.
Il Cosmo come sequenze fisse di parti separate, ordinate in modo che ne sia garantito il controllo, è anche lo scenario della sofferenza leopardiana.
E’ un lavoro del ’98, anno in cui Recanati celebra il bicentenario del suo Poeta, un progetto-mostra intitolato “La disperatissima sete- 8 pièces per Giacomo Leopardi”. Il piccolo Giacomo, affettivamente e intellettualmente vivacissimo, non era un bambino comodo nè tranquillizzante, la sua domanda d’amore, nell’accoglienza respinta, gli segna tutta la vita.
Leopardi è l’espressione più moderna e articolata delle sofferenze che le procedure dicotomiche possono infliggere al vivente specie se il soggetto in questione è dotato di grande complessità; il genio recanatese pone alla famiglia e ai suoi contemporanei il problema di un’interezza troppo forte, non omologabile, né organizzabile in parti convenzionali e mostra, nell’estrema sublimazione, la forza capace di superare il paradosso di un doppio vincolo: la grandissima arte trasforma l’oggetto amato che si rifiuta in oggetto cosmico, l’Infinito che lo accoglie.
Il tema della complessità è il modello astratto che articola ogni mia necessità di ricerca, di studio e di espressione.
L’assurdo che non si può tacere, anche se legalmente normalizzato, è il suo continuo travisamento: il sopruso, la fame, la guerra sono le derive di un’evoluzione psichica rimasta in buona parte sotto la pelliccia dei nostri antenati mentre all’evoluzione della clava viene sacrificata la maggior parte delle energie e degli ideali, dal tempo della pietra alle ultime generazioni dell’hi-tech.
Dentro queste scollature sono nate le opere degli ultimi anni.
“Il Corpo e la macchina” è la mostra tenuta ad Urbino nel 2002 con Della Rovere Arte e curata da Floriano De Santi.
Con “Il peso della leggerezza”, a Milano, continuo la riflessione sulla paura e sulla sua proiezione prevaricante; la Terra viene spogliata e sono diverse le visibilità conferite alle vittime.
La Fondazione Mastroianni con la mostra “Maria Micozzi o il mistero del corpo” raccoglie una serie di opere dai primi anni ottanta fino al 2003 seguendo un filo che in effetti mi appartiene: l’enigma del ‘corpo generante’ è il mio rovello di fondo, la galassia di senso in cui affondare la domanda.
Ultimamente la strada della necessità e del caso, che è poi quella di sempre, mi ha fatto incontrare Lilith, il personaggio-metafora per eccellenza dove quasi tutte le mie problematiche trovano un’ intrigante consonanza.
Lilith è la prima donna, è creata insieme con Adamo e non da una sua costola , come Adamo, è simile a Dio.
Quando Adamo le nega l’inversione della posizione sessuale, Lilith chiede:”Perché devo essere sottoposta a te? Eppure sono uguale a te.”
E’ rilevante il rigore teoretico con cui viene posta la domanda.
Non è altrettanto congrua la risposta che ribadisce la negazione, né la richiesta di aiuto che l’uomo fa al Signore, o l’ordine di tornare che gli angeli inviati portano a Lilith fuggita sulle rive del Mar Rosso.
La donna risponde agli angeli:” Come posso tornare da Adamo se non ho accettato la sua legge?”
Dio crea con la parola, Lilith usa la parola con coerenza, praticamente è l’unica intellettuale umana; Paolo di Tarso dirà “Mulier taceat in Ecclesia”
La domanda di Lilith è una metafora che porta lontano, per me ha portato anche alle ‘Città invisibili’ di Calvino, l’ultimo ciclo di opere che mi vede impegnata
Per l’autore livornese la città è la creatura dell’uomo per l’uomo dove l’uomo proietta la sue utopie; frammenti di felicità sperate, oggetti disillusi, memorie continuamente rivissute costruiscono, sfaldano, intrecciano città e relazioni: l’utopia è la felicità desiderata. l’organico vivo che fluisce lungo circuiti senza scissioni, la complessità che armonizza tutte i diversi in un continuum relazionale.
Il viaggio di Marco Polo e l’ascolto di Kublai Kan sono la stessa cosa, un cercare i segni della domanda che ognuno rivolge a se stesso e alla propria utopia, segni da comporre in una mappa, per tessere fili, canali, corrispondenze a cui tornare
L’utopia risponde alla domanda di senso del gruppo umano ed è intrecciata con i suoi segni, detta con i suoi nomi.
Attraversi i segni e i nomi il gruppo attiva i processi di significazione che tracciano i modelli interpretativi della propria realtà
“La domanda e l’utopia” è il titolo di queste ultime ricerche.
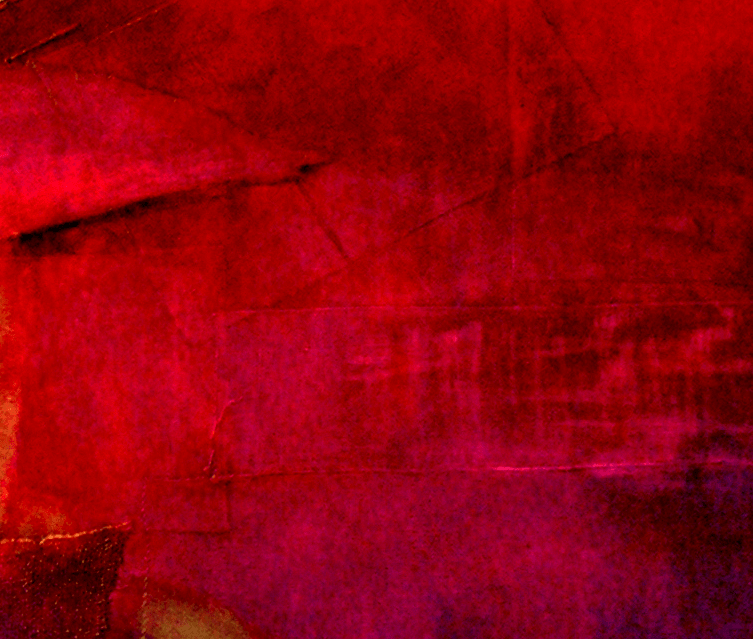

Lascia un commento